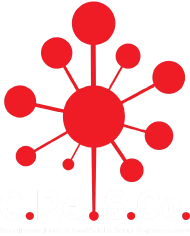Due Atti Senza Vedere
Da Raffaele Viviani a Eduardo De Filippo
regia di Gianluca Merolli
Raffaele Viviani ed Eduardo De Filippo, entrambi autori-attori-registi, hanno cantato Napoli, usando spesso le persone più umili come protagonisti delle proprie storie per descrivere una città che, zoppicando, tentava di rialzarsi dalle macerie della guerra. Nonostante le somiglianze e la stima che li legava, i due sono drammaturgicamente molto distanti. Viviani ha per protagonisti straccioni o mendicanti che urlano, si dichiarano, si ammazzano sempre in piazza o nei vicoli neri e maleodoranti. Eduardo racconta di persone solitamente benestanti, che sussurrano parole che non devono superare le quattro pareti di una stanza in cui stanno per soffocare.
“Secondo me non siamo diventati ciechi,
secondo me lo siamo,
ciechi che vedono,
ciechi che, pur vedendo,
non vedono.”
Due atti unici: La musica dei ciechi di Viviani del 1928, scritto dopo il primo conflitto mondiale, e Occhiali Neri di De Filippo del 1945, l’anno della fine del secondo conflitto mondiale. Tema principale dei due testi è la cecità, o la rappresentazione della cecità. La recita della luce e del buio, laddove l’una rappresenta l’incertezza del mondo e l’altro il regno della fantasia. Ferdinando, componente di un’orchestrina di ciechi, teme che don Alfonso, che con un occhio solo la fa da padrone, se l’intenda con la moglie. Ma “‘o cecato vede sempe ‘e ccose ‘e n’ata manera“.
Mario Spelta, reduce da una guerra che l’ha reso cieco, attende di togliere le bende dagli occhi scoprire se una cura gli restituirà la vista. vive la vita come una commedia e riacquista la sua libertà grazie ad un mistero. Quando Mario si abbandona definitivamente nelle mani della sorella e accetta una volta per tutte la propria condizione, è la salvezza, non è la fine. Perchè con quell’accettazione trasforma la crudezza del mondo in un’apoteosi immaginifica.
La cecità, come insegna Tiresia, ha a che fare con la conoscenza, col cadersi dentro. I due vogliono che si restituisca loro la vista forse proprio per fuggire da quell’abisso o per evitare che gli altri ci guardino dentro. E con l’esilio, Ferdinando allontana il tradimento e Mario il rischio di compassione.

Con la perdita della vista viene meno anche la percezione del tempo, del trascorrere delle ore e dei giorni, ma, soprattutto, il potere. E questi ciechi, o finti tali, diventano succubi di un padrone perchè “Nella terra dei ciechi, biato chi tene n’uocchio”.
Lo spazio del cieco si riduce, almeno inizialmente, a quello del suo corpo e il mondo sembra confondersi in un flusso continuo di cambiamenti che non sono più controllabili. Lo spazio si riduce, andando a combaciare col perimetro del suo corpo e il tempo, al contrario, si dilata.

La notte e il giorno si accavallano in un unico attimo senza fine. Nello spettacolo, questa privazione della vista si trasforma in aridità scenografica, nel rifiuto del superfluo. Solitudine e misericordia, sono la strada e la nostra piccola stanza dove viviamo e mettiamo in scena le due storie. Le luci racconteranno quest’alternarsi di vuoto e pieno, gettando sullo spettatore la responsabilità di indagare l’oscurità da un altro punto di vista.
In entrambi i testi, la cecità è vissuta dagli uomini, unendo l’istinto di distruzione a quello di creazione. Con uno sguardo femminile volto a proteggere e a guidare il cieco. L’uomo esce fuori dalla guerra e questa cecità, questa menomazione, non è altro che una possibilità per riflettere sulla solitudine dell’uomo, sulla sua impossibilità a viaggiare da solo, sul bisogno di mettere a servizio degli altri il proprio talento e le proprie sconfitte e, soprattutto, sull’incapacità dell’uomo contemporaneo di scrivere correzioni reali sul mondo, quel mondo che non vedo, non voglio vedere, e non riesco a cambiare.